
Prendo spunto dal titolo del celebre brano del R.E.M. “It’s the end of the world as we know it (and I feel fine)” per provare a capire se questa pandemia è davvero “la fine del mondo come lo conosciamo”, e soprattutto se c’è qualche motivo per “sentirsi bene”.
È probabile che la stagione estiva offrirà una pausa, un allentamento della ferocia dei contagi, i virus sono sensibili alla temperatura e la loro resistenza fuori dal corpo umano cala drasticamente col caldo. Questo dovrebbe darci respiro fino al prossimo autunno, ed è possibile che per quel tempo sia a buon punto la sperimentazione dei vaccini, o che siano stati messi a punto dei farmaci efficaci. Anche in questo caso però rimarrebbero delle incognite: nessuno sa se l’aver sviluppato anticorpi protegga realmente da un secondo contagio, nessuno sa quanto il virus muti nel corso del tempo, e quindi se il vaccino stesso possa offrire una protezione permanente o solo stagionale, come nel caso del vaccino per l’influenza, che peraltro non garantisce neppure la certezza di non ammalarsi. E dunque andrebbe messa in conto la possibilità concreta di una lunga fase davanti a noi di convivenza col virus, una fase che richiederà adattamenti profondi del nostro modo di vivere, “la fine del mondo conosciuto”, appunto.
La prospettiva della fine del mondo comporta certamente aspetti angoscianti, primo fra tutti l’accresciuta consapevolezza della propria fragilità, precarietà, mortalità. La paura del dolore e della morte ha spesso spinto l’uomo verso la superstizione, la magia, la scaramanzia. Ma può anche spingerlo verso forme estreme di chiusura, verso la xenofobia, può comportare una minaccia molto concreta, il rafforzamento di nazionalismi e populismi basati appunto su reazioni emotive, istintive.
Si tratta di rifiuto della realtà puro e semplice.
Un virus non conosce confini, e le epidemie circolavano tranquillamente sia quando il mondo era unito sotto l’impero di Roma, sia nella caotica frammentazione medievale, sia all’epoca d’oro degli Stati sovrani. Chiudere una zona rossa per evitare il diffondersi del contagio ha senso, chiudere genericamente i confini di uno Stato ne ha molto meno, come la pandemia ha appunto dimostrato.
La sensazione di angoscia viene ovviamente esaltata dalla crisi economica, la prospettiva di non guadagnare, di perdere il lavoro, di non riuscire a mantenersi si somma alla pura e semplice paura di ammalarsi, e questo può indurre ancora di più alla chiusura, all’isolamento, persino alla depressione.
Alcune difficoltà saranno oggettive, viaggiare sarà presumibilmente più complicato, difficile e costoso di prima, sia per quanto riguarda le lunghe percorrenze, sia per i trasporti urbani. Se un autobus deve limitare la sua capacità ad un quarto o meno di quella precedente, si capisce bene quanto le città dovranno riorganizzarsi, attraverso orari flessibili, ingressi scaglionati, uso estensivo del lavoro da casa, ampliamento della mobilità individuale sostenibile, che poi significa principalmente biciclette, monopattini, bike e car sharing.
Ma l’uso estensivo e permanente dello smartworking implicherà anche una riorganizzazione delle case private, con una preziosa porzione di spazio privato (per chi ne dispone) da dedicare in modo non occasionale alle funzioni di ufficio; il re-design domestico andrà insomma di pari passo col re-design urbano, nella faticosa creazione di una nuova normalità.
Ci si può anche attendere l’esplosione di un conflitto tra libertà personale salute pubblica. Questo conflitto è rimasto sotto traccia nel periodo del lock down, perché si era tutti in una condizione di paralisi da panico. Ma cosa succederà quando saranno disponibili le app di tracciamento? La gente accetterà di sottoporsi alla localizzazione?
La questione di fondo è il grado di fiducia nelle istituzioni. Sappiamo bene che moltissime app già ci tracciano, ad esempio Google, Tripadvisor, tutti i navigatori, i programmi meteo e in generale tutte quelle app a cui abbiamo consentito l’accesso alla nostra posizione (WhatsApp, Facebook, Instagram, Telepass, Stocard, ecc.). Sappiamo bene che la geolocalizzazione è uno dei tanti dati personali di cui con una certa liberalità autorizziamo l’uso a scopi commerciali, ma per qualche motivo il fatto che l’Autorità possa accedere alla nostra posizione, nonostante tutte le rassicurazioni sull’anonimato dei dati, ci preoccupa molto di più, e tanto di più quanto di meno ci fidiamo del Governo. C’è evidentemente la percezione di un rischio di controllo autoritario, che temiamo possa rimanere anche dopo la fine dell’emergenza. Paradossalmente, l’eventualità di restrizioni molto più violente della libertà, come zone rosse e lockdown locali nel caso di ritorno dell’epidemia, sembrano preoccupare di meno, proprio per il loro carattere chiaramente emergenziale e quindi più sicuramente temporaneo.
Non va dimenticato che controlli sierologici, certificati di immunità e simili rischiano di innescare deviazioni e discriminazioni assai pericolose in un momento gravissimo di crisi economica ed occupazionale, come si può intuire: ad esempio, la tentazione di favorire per l’assunzione chi possieda un “passaporto d’immunità” rispetto a chi non lo possiede sarà forte.
Nonostante tutti questi rischi potenziali, la crisi innescata da una pandemia potrebbe tuttavia presentare persino delle opportunità di sviluppo positivo, delle occasioni perché la “fine del mondo conosciuto” favorisca la nascita di un mondo almeno un po’ migliore del precedente.
- La prima opportunità è legata al fatto che questa pandemia rappresenta la prima sfida globale in cui l’umanità intera si trova veramente ingaggiata. Da parecchio tempo sentiamo dire che il mondo contemporaneo ha abolito le distanze, compattato l’umanità, ma di fatto quando gli interessi divergono questo mitico “fronte unitario” si sgretola come un castello di sabbia. In questo caso invece la sfida è davvero globale, collettiva, l’umanità da una parte contro il virus dall’altra; ed è la prima volta che l’umanità sembra prendere atto di un’identità comune. La comunità scientifica lavora alla ricerca di farmaci efficaci, o di un vaccino, con un’intensità che non si era mai vista, scienziati di tutti i continenti mettono in comune informazioni, risultati e teorie letteralmente a ritmo quotidiano, e questo è un fenomeno estremamente importante.
- La creazione di un’identità comune è il primo passo perché possano essere affrontati appunto con spirito unitario e non ciascuno secondo il proprio tornaconto particolare i problemi della sostenibilità e del cambiamento climatico, che sono in assoluto le minacce maggiori che abbiamo di fronte. Al tempo stesso, abbiamo imparato che è possibile uno stile di vita con un impatto sul pianeta decisamente inferiore rispetto al recente passato e questo, se non altro, farà cadere parecchi alibi.
- Un altro elemento positivo piuttosto importante è la constatazione che le grandi reti infrastrutturali hanno retto l’impatto di uno “stress test” imprevisto e violento. Questo non era affatto scontato, a cominciare da internet. Pare che l’effetto del lock down sia stato un incremento praticamente istantaneo dell’ordine del 30% del traffico in rete. Ma ha retto bene anche la rete della logistica, le merci sono arrivate al supermercato con regolarità, a parte qualche sporadico assalto alimentato dal panico. Hanno retto anche le consegne a domicilio, corrieri e riders, che forse adesso smetteranno di essere invisibili. Molti ristoranti, pizzerie negozi sono riusciti a mantenere un minimo di attività attraverso le consegne a domicilio di cibi e merci ordinabili sul loro sito web, una modalità che potrebbe rimanere anche in futuro, micro-reti locali di circolazione di merci a disposizione soprattutto delle persone più anziane. Ogni negozio che non abbia ancora provveduto farebbe probabilmente bene ad organizzarsi con un piccolo sito web ed un accordo con dei riders.
- Non ha retto altrettanto bene la rete sanitaria, indebolita negli anni da tagli di budget ma forse anche da qualche elemento ideologico. Il fatto stesso di trovarsi ad ammirare l’eroismo di medici ed infermieri, indica che il sistema non ha retto a sufficienza. Abbiamo scoperto di avere metà dei posti letto rispetto alla media europea, pur con una popolazione più anziana della media. È vero che l’emergenza è giunta all’improvviso, ma forse potrebbe essere una buona idea per il futuro estendere a tutte le reti gli “stress test” ideati e praticati ormai da tempo per verificare la capacità di resistenza delle banche.
- Più in generale c’è stato un consolidamento dell’uso di strumenti digitali ormai generale. Videoconferenze via web per un pubblico di over 70 sarebbero state impensabili solo pochi mesi prima della pandemia. Sarebbero state semplicemente rifiutate.
- L’uso di strumenti tecnologici avanzati fa parte di un generale sentimento più favorevole a scienza e tecnologia, gli scienziati sono tornati a parlare in televisione (fin troppo), e quando il vaccino arriverà, mi aspetto che sia generalmente bene accolto soprattutto se nel frattempo dovesse verificarsi la temuta “seconda ondata”, il ritorno del virus in autunno.
- Più in generale, si intravede una rivalutazione delle competenze, dopo anni di trionfo del dilettantismo. Si rivede anche lo Stato, come sempre accade quando le cose vanno male, si rivalutano la medicina di base e il sistema sanitario in generale, tutte cose di cui è invece facile dimenticarsi quando le cose vanno bene. Val la pena ricordare che i sistemi sanitari nazionali sono nati dopo la tremenda epidemia di spagnola del primo dopoguerra. Oggi ci si torna a chiedere se il diritto alle cure mediche non debba essere incluso tra i diritti fondamentali dell’uomo.
- C’è insomma qualche segnale di arretramento del pensiero liberista che ha dominato il mondo negli ultimi trent’anni, diciamo dalla caduta del Muro in avanti. Ed in questo arretramento comincia ad emergere la voce di chi da tempo segnala il pericoloso aumento delle diseguaglianze nei Paesi occidentali causato dalla globalizzazione, l’assottigliamento progressivo del ceto medio (quello che una volta si chiamava “borghesia”) e la polarizzazione tra un ristretto numero di ricchi sempre più ricchi ed una popolazione sempre più povera. La crisi economica prodotta dall’ epidemia non potrà che esacerbare questo stato di cose, con esiti potenzialmente destabilizzanti. È importante è che questo argomento venga messo all’ordine del giorno. Così come si riesce a controllare attraverso le certificazioni la qualità di beni e servizi, dovunque essi siano prodotti, non dovrebbe essere impossibile realizzare un sistema di controllo che certifichi anche il rispetto di livelli minimi di protezione e retribuzione del personale, dovunque si trovi la produzione.
- A proposito di globalizzazione, si è constatato durante l’emergenza come le filiere eccessivamente delocalizzate siano inevitabilmente fragili. Se per realizzare un prodotto si ha bisogno di componenti che arrivano da una moltitudine di Paesi, allora un problema imprevisto in uno di questi Paesi mette a rischio tutta la catena. È quello che abbiamo sperimentato, prima con il lockdown cinese, successivamente con quelli dei vari Paesi sfalsati fra di loro. Sarà necessario probabilmente predisporre catene produttive ridondanti, con gli stessi componenti che possono essere approvvigionati in Paesi diversi, oppure semplicemente più corte: produrre dove si vende, realizzare Supply Chains locali, commercio a chilometro zero o quasi, con beneficio per il pianeta.
- L’umanità è una nave in tempesta in questo momento, e quando una nave attraverso la tempesta è importante avere un buon capitano. Ma qui, proprio non ci siamo: la leadership dell’Occidente è stata a lungo saldamente nelle mani degli Stati Uniti, i quali però già da qualche tempo, e massimamente con la presidenza attuale, hanno palesemente rinunciato ad esercitarla. La Cina dal canto suo sembra concentrata esclusivamente sui propri interessi, mentre l’Europa è sempre stato un gigante economico ma un nano politico.
Ma in questa tempesta nessuno si salva da solo.
E forse è proprio l’Europa, quella a cui questa crisi potrebbe dare una buona volta l’impulso decisivo per decollare e prendere in mano, se non quello del mondo, almeno il proprio destino.
“You miss too much these days if you stop to think”
U2 – Until the end of the world













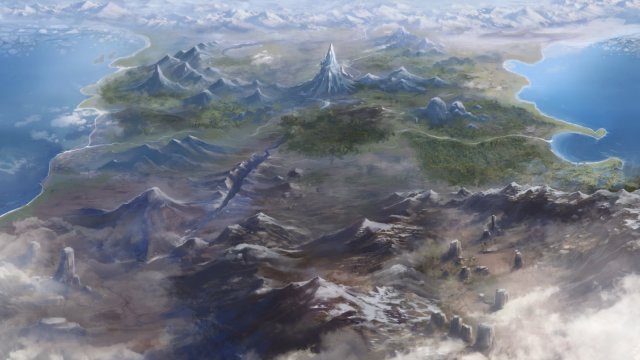 (
(